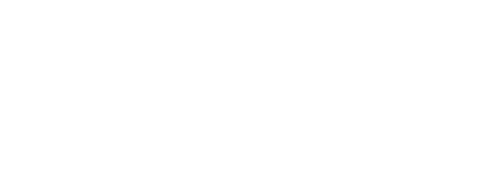La Francia ha compiuto un passo significativo nella lotta contro i Pfas, approvando una legge che ne vieta l’uso in una serie di prodotti di largo consumo. L’Assemblea Nazionale ha dato il via libera definitivo al provvedimento, che a partire dal 1° gennaio 2026 impedirà la produzione, l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione di Pfas in diverse categorie di prodotti, tra cui prodotti tessili e impermeabilizzanti per abbigliamento, cere per sci e snowboard, vernici e cosmetici. Dal 2030 il divieto verrà esteso all’intero comparto tessile, con un’unica eccezione per gli indumenti protettivi destinati a vigili del fuoco e forze dell’ordine.
Cosa sono i Pfas e perché sono pericolosi
I Pfas (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) sono una famiglia di composti chimici che comprende tra 5.000 e 10.000 sostanze. Grazie alla loro resistenza all’acqua, al calore e alla corrosione, sono utilizzati in prodotti antiaderenti, impermeabili e isolanti elettrici. Li troviamo in indumenti tecnici, calzature, utensili da cucina, lenti per occhiali, stent cardiologici e persino in alcuni farmaci.
Proprio la loro elevata stabilità li rende pericolosi per la salute e l’ambiente: si accumulano nell’ecosistema e negli organismi viventi, con effetti negativi sulla fertilità, il sistema immunitario, il metabolismo e un aumento del rischio di alcuni tipi di tumore.
L’impatto sul settore tessile e della moda
L’industria tessile e della moda è tra le più coinvolte dalla normativa, visto l’uso diffuso dei Pfas per conferire proprietà idrorepellenti e antimacchia a tessuti e calzature. La transizione verso alternative sostenibili richiederà ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, per individuare materiali innovativi e trattamenti alternativi come polimeri bio based e cere vegetali.
L’impatto sarà particolarmente significativo per i brand outdoor, sportswear e moda funzionale, che dovranno ripensare intere linee di prodotto. Alcuni marchi, come Patagonia, hanno già avviato la transizione verso materiali privi di Pfas, ma la sfida rimane complessa e nei commenti delle aziende prevale la cautela.
Francesca Rulli, co-founder di Ympact e ideatrice del framework 4sustainability, richiama l’industria della moda al dovere di eliminare dai processi produttivi l’uso di sostanze di cui la scienza ha provato la pericolosità: “Negli ultimi decenni, la corsa a tessuti antimacchia e impermeabili ha portato a un uso eccessivo di queste sostanze, spesso anche dove non strettamente necessario: ci siamo abituati a non preoccuparci delle macchie sui vestiti e a pretendere prestazioni idrorepellenti estreme, anche in capi di uso quotidiano. Inoltre, i Pfas vengono impiegati come ausiliari nei processi di tintura, stampa e finissaggio per migliorarne le performance. Se consideriamo i rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente, è indispensabile ripensare sia i processi produttivi che le specifiche di prodotto, a partire proprio da quei casi in cui l’uso di queste sostanze serve più a evitare resi che a rispondere a una reale esigenza funzionale. Certo, educare il consumatore non è semplice, ma un’informazione chiara potrebbe indurre tante persone a sostenere questa transizione”.
Misure fiscali e controlli ambientali
Oltre ai divieti progressivi, la legge introduce una tassazione sui Pfas nei prodotti destinati ai consumatori, per incentivarne la riduzione prima delle scadenze imposte. I dettagli applicativi sono ancora in via di definizione.
Secondo Giancarlo Di Blasi, Research and Development Director di Brachi Testing Services, “il vero nodo da sciogliere sarà stabilire con precisione le modalità analitiche e le soglie di concentrazione ammesse: un aspetto tecnico ma decisivo per l’efficacia del provvedimento. Sarà interessante – sottolinea – capire se la Francia sceglierà di estendere la restrizione anche alle catene corte dei PFAS, come già previsto a livello europeo dal Regolamento (UE) 2024/2462 per il PFHxA (C6), oppure se adotterà un approccio simile a quello californiano, basato sulla misura del Fluoro Totale presente nei prodotti. In quel caso, bisognerebbe stabilire limiti chiari e ambiziosi, considerando che in California il contenuto massimo, fissato a 100 mg/kg, verrà dimezzato a partire dal 1° gennaio 2027».
La normativa prevede anche il controllo obbligatorio dei Pfas nell’acqua potabile, rafforzando la legislazione europea che, dal 1° gennaio 2026, imporrà il monitoraggio di venti inquinanti di questo gruppo nei Paesi membri. La Francia, inoltre, includerà il Tfa (acido trifluoroacetico) – il Pfas più diffuso, secondo Greenpeace – tra le sostanze da monitorare nelle acque e nell’ambiente. I risultati delle ispezioni ambientali saranno pubblicati annualmente e resi accessibili online.
Verso un divieto europeo dei Pfas?
I primi passi dell’UE risalgono al 2009, con la messa al bando dell’acido perfluoroottansolfonico (Pfos), ritenuto “potenzialmente cancerogeno” dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. Nel 2020, la stessa sorte è toccata all’acido perfluoroottanoico (Pfoa) – classificato come cancerogeno – e, più recentemente, all’acido perfluoroesansolfonico (Pfhxs), utilizzato per produrre la schiuma degli estintori. Ora è sul tavolo una proposta per generalizzare le restrizioni a tutti i Pfas: a febbraio 2023, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia hanno chiesto all’European Chemicals Agency (ECHA) di rivedere il regolamento Reach in questo senso. Nel suo piano d’azione, il governo francese ha dichiarato l’intenzione di unirsi a questi Paesi per sostenere la richiesta, salvo muoversi in autonomia, come abbiamo visto, ponendosi di fatto come modello di riferimento.
Una sfida da cogliere
Se altri Paesi seguiranno l’esempio, il settore tessile dovrà accelerare la ricerca di alternative per rimanere competitivo in un contesto normativo in evoluzione, traducendo gli investimenti in processi produttivi più sicuri e sostenibili in vantaggio.
Si tratta di una trasformazione radicale per l’intero comparto e la legge francese potrebbe rappresentare l’innesco: dall’innovazione dei materiali alla revisione delle filiere produttive, fino alla necessità di bilanciare sostenibilità ambientale ed esigenze economiche.
Il dibattito è aperto e il 2026 si avvicina. L’industria della moda sarà pronta a raccogliere la sfida?
L’eliminazione dei Pfas, secondo Rulli, richiede un percorso strutturato, simile alla creazione di un sistema di gestione delle sostanze chimiche lungo la filiera.
“Il primo passo – spiega – è la valutazione del rischio, analizzando i prodotti e le catene di fornitura coinvolte. Poi, è essenziale raccogliere dati dai fornitori per individuare eventuali esposizioni a queste sostanze e verificarli con test di laboratorio. La ricerca di alternative sostenibili, dalle materie prime ai trattamenti, deve essere accompagnata da una stretta collaborazione con i fornitori per garantire una transizione efficace. Altrettanto fondamentali sono il monitoraggio dei progressi, la formazione interna per sensibilizzare sui rischi e l’educazione del consumatore. Infine, la trasparenza: pubblicare dati verificati e ottenere certificazioni di sostenibilità rafforza l’impegno dell’azienda. Questo processo stimola anche l’industria chimica a innovare, sviluppando formulazioni più sicure. Più aziende adotteranno questa strategia, maggiore sarà la spinta in ricerca e innovazione”.